Come si forma, quali sono le finestre critiche, l’importanza dell’ambiente, l’allenamento emotivo, la libertà del bambino e l’intenzione di leggere quel libro aperto che è nostro figlio.
Intervista a Francesca Mastorci, ricercatrice dell’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa e docente UNIPI “Comportamento, Stress e Salute”.
- Ci racconti il cervello dei bambini e le sue funzioni, partendo dall’anno zero?
Il cervello di un bambino è innanzitutto differente rispetto a quello di un adulto. La principale differenza è il numero di neuroni presenti alla nascita e del numero delle connessioni, le sinapsi, che si sviluppano nel corso della vita: nel cervello dell’adulto i neuroni sviluppano trilioni di connessioni, appunto le famose sinapsi, in costante via di sviluppo e definizione nel bimbo. Questo ci porta a pensare che, queste connessioni cerebrali, le sinapsi, che si creano nel bambino nascano sostanzialmente sulla base di quello che noi adulti gli offriamo quindi in base all’ambiente, l’ambiente in cui il bimbo vive. Questo ci deve far riflettere.
Un neonato alla nascita possiede sostanzialmente quasi la totalità dei neuroni ma è soltanto più o meno intorno al terzo anno di età che il cervello inizia ad andare verso quel fenomeno meraviglioso che è la neurogenesi ippocampale e che raggiunge il maggior sviluppo in termini di neuroni neoformati intorno al terzo anno di età quando abbiamo 100 miliardi di cellule che un giorno andranno a creare il cervello adulto e arriveranno a 150 miliardi di collegamenti di sinapsi tra loro.
La neurogenesi che comincia intorno al terzo anno di età e che è stata una scoperta delle neuroscienze perché inizialmente si pensava che il nostro cervello fosse cablato alla nascita e che poi fosse soltanto una lenta morte neurone nel corso della vita dal momento in cui veniamo al mondo e invece non è così grazie a questo fenomeno. Questo comporta che il cervello del bambino che molto plastico si va a definire giorno per giorno, creando quello che sarà il cervello dell’adulto cominciando dai primissimi mesi di vita dove sono attive soltanto alcune delle specifiche aree cerebrali deputate ad avere dei comportamenti automatici, non coscienti in un certo senso, che può avere un bambino appena nato e che sono sostanzialmente legati al pianto, alla ricerca del cibo, all’afferrare degli oggetti, altre aree sono ancora immaturee sono però responsabili di andare a registrare e memorizzare informazioni provenienti dal mondo esterno che andranno a definire il cervello dell’adulto.
Questo significa che l’ambiente sociale, emotivo, l’ambiente in generale in cui il bimbo vive fin dai primi giorni di vita andrà a plasmare e definire molto bene comportamento e emozioni che avrà da adolescente o da adulto. Intorno all’anno e mezzo di età circa quando si sviluppa il linguaggio compare una nuova funzione che prima non c’era, quella di andare a sperimentare quello che poi da adulto diventerà una sperimentazione critica, fase legata a sensazioni negative, alla gestione delle emozioni che si vengono definendo nel bambino. Nei primi 3 anni non è ancora attiva “l’area filtro” ovvero il cervello del bimbo prende tutto per buono, non ha la mente critica ma memorizza tutte le informazioni nelle diverse aree che sono in parte inaccessibili alla coscienza, aree strettamente correlate con il sistema limbico, la parte più ancestrale del nostro cervello, che è quella correlata alle emozioni e non solo al riconoscimento emotivo ma anche al tarare le proprie emozioni in funzione degli stimoli che il bambino andrà a vivere.
Tra i 3/4 anni il cervello cresce, si definisce, si plasma, abbiamo la neurogenesi, e vanno a definirsi tutte le capacità più critiche che vanno a comprendere la conseguenza delle azioni che il bambino fa. Viene associato il comportamento alle conseguenze, fino ad arrivare ai 5/6 anni dove il cervello è maturo ( non termina la sua maturazione): sono state definite le strutture neurali che sottendono i vari comportamenti tipici dei bambini di quell’età. E’ chiaro che il cervello di un bimbo appena nato non è un cervello computazionalmente attivo, ha bisogno di stimoli esterni e di vivere in un ambiente sensoriale che possa andare a modulare queste connessioni che si stanno definendo e la morfologia, l’anatomia, la struttura del cervello accompagna questa funzione plastica che ha di andarsi a definire . Lo stesso asse ipotalamo-ipofisi-cortico-surrene che è l’asse che regola la risposta di stress in tutti noi in un bambino appena nato non è del tutto sviluppato. Già significa che i sistemi correlati allo stress che sono alla base di comportamenti anche disfunzionanti nell’età adulta vanno proprio a definirsi in maniera anatomica e funzionale intorno al terzo mese di vita. Il bimbo anche se apparentemente non manifesta comportamenti legati allo stress o pattern comportamentali è una spugna che apprende in maniera non critica tutto quello a cui viene esposto. Secondo anche le teorie degli anni 60 di Barker si parla del fatto che le patologie croniche dell’età adulta vanno a trovare il loro esordio addirittura nel periodo fetale.
Questo ci fa capire che comunque anche in un periodo che è fuori da ogni capacità del bambino di poter intervenire su se stesso come una spugna va ad astrarre comportamenti materni, li memorizza per poi tirare fuori in maniera patologica disfunzionale tutta una serie di vulnerabilità e suscettibilità a manifestare psicopatologie nell’adolescenza e se le porta nell’età adulta. Il cervello del bambino è qualcosa in continuo divenire, è una finestra molto critica.
Nella vita abbiamo due fasi di vulnerabilità. Una di queste non è tanto l’infanzia quanto il periodo perinatale che va dagli ultimi 3 mesi di gravidanza ai primi 3 mesi di vita perché è proprio lì che si va a definire il nucleo di quelle che saranno le nostre risposte comportamentali nell’età adulta. Poi è chiaro che l’anatomia, la morfologia, la neurogenesi ippocampale che ci fa crescere i neuroni e ci da la possibilità di creare nuove connessioni sicuramente queste renderanno il cervello via via sempre più attivo fino a farlo arrivare all’adolescenza dove il cervello è computazionalmente attivo ma in modo straordinario va a resettare le sue dinamiche interne grazie ad un fenomeno neurobiologico che si chiama cruning sinaptico che va a potare, tagliare quelle connessioni che si sono create durante l’infanzia e di dare la possibilità a quel bambini/adolescente di andare a creare nuove connessioni e in qualche modo a fare un RESET su quelle che sono le proprie risposte comportamentali. Abbiamo una seconda chance ma allo stesso tempo è un’altra finestra di rischio.
Addirittura si collega l’ insorgenza della sintomatologia depressiva dell’adolescenza alla vita intrauterina.
Il cervello memorizza ciò che la madre sta vivendo e che passa la bambino attraverso la placenta e che può aumentare o meno la sua vulnerabilità. Studi recenti su madri nell’ultimo trimestre di gravidanza durante l’11 settembre vittime di un trauma o di un lutto: i bimbi nati una volta adolescenti avevano una alterazione del cortisone rispetto ai bambini che non avevano vissuto una situazione simile nel periodo fetale. Lo stress della madre aumenta la soglia di reattività del cortisone durante l’adolescenza. Il cortisone è l’ormone dello stress per eccellenza, avere un alto cortisone vuol, dire che si ha un’alta vulnerabilità alla risposta di stress o anche che lo stress è intimamente correlato all’insorgenza di tutta una serie di patologie fisiche, cronico degenerative e somatiche. Tutto nasce dalla pancia della mamma, non solo nasce la vita ma anche le nostre dinamiche comportamentali.
Cosa si può fare dunque per migliorare la situazione se non si è in prossimità di una di queste finestre o nel caso di bambini adottati?
L’empatia è correlata alla capacità di rispondere in maniera corretta alle emozioni e oggi si è visto che non è una sola funzione degli adulti. Esiste in proposito uno studio dell’università del Michigan su bambini seguiti per 17 anni in cui si è visto che già da piccolo il bambino ha la tendenza biologica a sviluppare empatia. Da qui sono nati studi sull’esposizione dei bambini alle cosiddette “medicine alternative” e a tecniche di rilassamento ed è nata la branca della psicologia positiva dove si lavora sul riconoscimento delle emozioni nei bambini.
In Italia la Montessori, pioniera in ambito educativo, già aveva capito oltre un secolo fa che è possibile andare a modulare la mente del bambino, che ovviamente si comporta diversamente dalla nostra, ma che cresce e si sviluppa e va ad assorbirei maniera del tutto naturale tutto ciò che è presente nell’ambiente in cui è esposto.
Consiglio quindi di partire dall’ambiente e di creare un ambiente, emotivo sociale naturale che in qualche modo consenta al bambino di svilupparsi in maniera più libera possibile; l’ambiente è fondamentale per aiutare a sprigionare quell’empatia e a riconoscere le emozioni non tanto degli altri ma le proprie.
Lasciare libero il bambino..ci spieghi meglio?
In generale la libertà significa dare al bambino la capacità di esprimere al meglio la propria creatività o quelle dinamiche interiori che il bimbo non conosce; ecco perché è nata quella parte delle neuroscienze supportata dalla psicologia che è legata al riconoscimento delle emozioni, alla competenza emotiva, riconoscere e nominare le proprie emozioni, perché questo porta a regolarle. Questo allenamento emotivo associato alla libertà di dare al bambino la capacità di poter fare tutto quello che gli passa per la testa chiaramente secondo degli schemi che devono inevitabilmente esserci: come ho detto il cervello del bambino non è un cervello critico, la criticità gliela diamo noi adulti, siamo noi a dirgli se quell’azione è giusta o sbagliata.
La libertà deve sempre muoversi proprio all’interno di qualcosa di ben definito proprio perché altrimenti proprio perché il bambino è plastico, può andare a modulare risposte emotive e comportamentali disfunzionanti che nel lungo termine possono creare problematiche. Il bambino, anche piccolo, non può essere lasciato solo a mangiare sotto al tavolo. Devono esserci delle regole, le regole che lo aiutano. Incanalare non soltanto comportamenti ma anche le proprie emozioni, aiutano a capire e a definire quella coscienza critiche che porterà quel bambino. Ad essere un adolescente con una identità emotiva, culturale e sociale; diversamente cresce senza avere riferimenti a livello neurobiologico.
Un libro utile ai genitori?
Mi cogli impreparata… il libro che dobbiamo noi genitori aver ben chiaro è la lettura del comportamento dei nostri figli, è un libro aperto in continua scrittura e dobbiamo anche noi genitori avere gli strumenti per poterlo leggere correttamente altrimenti diventiamo disfunzionanti anche noi. Bisogna capire, conoscere il propio figlio, guardarlo negli occhi, capire i, perché di quello comportamento. Ascolto, comprensione, osservazione e mettersi in posizione di apertura e capire quelli che sono gli aspetti che pili figlio predilige e capire il perché di quell’azione eventualmente sbagliata. La comprensione è alla base del rapporto genitore figlio anche per un rapporto corretto con la società.

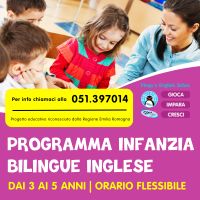

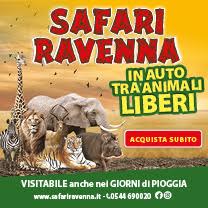



{ 0 comments… add one now }